Pensare ai festival ci fa venire in mente dei libri, pensieri che abbiamo letto, pagine che abbiamo solo sfiorato, viaggi di cui abbiamo sentito parlare o che ci hanno raccontato.
Un modo diverso per parlare dei festival, del loro modo di essere, di venire creati, visti e vissuti, di quello spazio-tempo d’eccezione che offrono ad artisti e spettatori.
Altri mondi, altre storie.
1. Fiesta (Il sole sorgerà ancora), di Ernest Hemingway (1926)
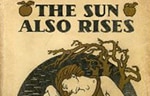 “Magari andando avanti s’impara qualcosa. A me non importava sapere cosa fosse tutta la faccenda. Forse però se scoprivate come viverci, potevate anche capire che cosa l’intera faccenda fosse […]”. |
| PERCHÉ: È un esordio; il Festival di Pamplona è pur sempre un festival; è un capolavoro per la costruzione dei dialoghi |
| APPROFONDIMENTI: La recensione sul “New York Times” (31 ottobre ’26) → |
2. Città in festival. Nuove esperienze di marketing territoriale,
a cura di Marco Paiola e Roberto Grandinetti (2009)
|
|
| PERCHÉ: Alla fine del primo decennio 2000 si faceva il punto su cosa fosse un festival e cosa potesse diventare. Cosa è cambiato? |
| APPROFONDIMENTI: L’introduzione del libro sul sito di FrancoAngeli → |
3. Teatro nel Rinascimento. Roma 1450-1550, di Fabrizio Cruciani (1983)
|
|
| PERCHÉ: L’idea di festa come filtro per capire il teatro, in un capolavoro di Cruciani dedicato al Rinascimento che però sa parlare (e tanto) anche del nostro tempo |
| APPROFONDIMENTI: La bibliografia di Cruciani sul sito di “Teatro e storia” → |
4. Laboratorio ’75, a cura di Franco Quadri (1979)
|
|
| PERCHÉ: La Biennale di Ronconi: uno spartiacque nel Nuovo Teatro italiano e per il concetto, il modo, il senso dei festival |
| APPROFONDIMENTI: Lo spettacolo Utopia sul sito di Luca Ronconi → |
5. Organizzare teatro a livello internazionale. Linguaggi, politiche, pratiche, tecniche, a cura di Mimma Gallina (2008)
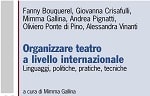 “(…) un festival è una particolare concentrazione nello spazio e nel tempo di spettacoli e manifestazioni connesse, legati a specifici generi, temi, tendenze, o comunque ad un progetto culturale esplicitato”. |
| PERCHÉ: è il vademecum dell’organizzatore teatrale che imposta azioni culturali. |
| APPROFONDIMENTI: L’introduzione al libro sul sito di Franco Angeli → |
6. Fêtes et civilisations, di Jean Duvignaud (1973)
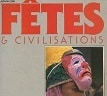 “I muri parlano. Si viene investiti dall’assembramento casuale di gruppi che si riuniscono, si incontrano, vanno e vengono ( … ) Nessuno è davvero attore e nessuno è solo spettatore: lentamente, nascono parole e gesti che non si rifanno a forme più o meno stabilite”. |
| PERCHÉ: il Festival, come la festa, modifica le comunità che vi prendono parte, alterando relazioni, forme, modalità partecipative. |
| APPROFONDIMENTI: La bibliografia di Jean Duvignaud sul sito della casa editrice Actes Sud → |
7. Il valore degli eventi. Valutare ex ante ed ex post gli effetti socio-economici, esperienziali e territoriali, di Sergio Cherubini, Enrico Bonetti, Gennaro Iasevoli, Riccardo Resciniti (2009)
|
|
| PERCHÉ: Dallo sport al festival culturale: una ricerca scientifica sulla capacità di creazione di valore degli eventi; un approccio metodologico in grado di coinvolgere il lettore alla scoperta dei diversi livelli legati al processo e alle strategie insite nell’organizzazione di un evento. |
| APPROFONDIMENTI: La recensione di Lucio Argano sulla rivista Economia della cultura (condivisa da FrancoAngeli) → |
8. Considera l’aragosta, di David Foster Wallace (2006)
|
|
| PERCHÉ: Fra le altre cose, Wallace ci ha insegnato il reportage: tante volte ha messo su carta esperienze immersive e intensive, cronache da progetti, festival, manifestazioni, tracciando equilibri sorprendenti fra giornalismo ed etnografia, analisi e racconto, coinvolgimento e distacco, particolare e generale (in questo libro: gli Oscar del porno, campagne elettorali itineranti, sagre dell’aragosta). |
| APPROFONDIMENTI: Audio-intervista sul volume a Wallace → |
 “[…] è sempre più forte il richiamo esercitato da occasioni di incontro nelle quali la moltitudine, la folla, il caos sono una delle componenti dell’evento, a sottolineare il senso dell’appartenenza a un rito collettivo di fruizione da parte di una massa che si auto-seleziona condividendo un comune interesse”.
“[…] è sempre più forte il richiamo esercitato da occasioni di incontro nelle quali la moltitudine, la folla, il caos sono una delle componenti dell’evento, a sottolineare il senso dell’appartenenza a un rito collettivo di fruizione da parte di una massa che si auto-seleziona condividendo un comune interesse”.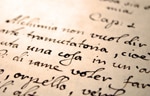 “Teatro è un luogo metaforico concretizzato in un tempo e in uno spazio trasformato, non quotidiano, reso più che reale, all’interno del quale ci si pone o si viene posti; teatro non è una forma specifica di espressione ma una situazione in cui si celebra una cultura (anche nel senso antropologico del termine) nelle sue forme ideali, dove il possibile assume realtà e il pensabile diventa espressione”.
“Teatro è un luogo metaforico concretizzato in un tempo e in uno spazio trasformato, non quotidiano, reso più che reale, all’interno del quale ci si pone o si viene posti; teatro non è una forma specifica di espressione ma una situazione in cui si celebra una cultura (anche nel senso antropologico del termine) nelle sue forme ideali, dove il possibile assume realtà e il pensabile diventa espressione”. “La data dell’estate ’75 diventa un crocevia […]. Mentre il laboratorio uscito dagli anni sessanta cerca la via della comunicazione più diretta, il nuovo laboratorio risale questa comunicazione a analizzarla. Nell’uno e nell’altro caso è il concetto di rappresentazione che salta”.
“La data dell’estate ’75 diventa un crocevia […]. Mentre il laboratorio uscito dagli anni sessanta cerca la via della comunicazione più diretta, il nuovo laboratorio risale questa comunicazione a analizzarla. Nell’uno e nell’altro caso è il concetto di rappresentazione che salta”. “(…) l’evento culturale, per la sua stessa natura, ha come principio ispiratore quello di favorire lo sviluppo della “cultura” a vantaggio della collettività verso cui l’evento si rivolge. In tal senso, la naturale distinzione in effetti positivi (benefici) e negativi (costi) risulterebbe limitata se non si applicasse anche quella in ritorni ‘tangibili’ (…) e ‘intangibili'”.
“(…) l’evento culturale, per la sua stessa natura, ha come principio ispiratore quello di favorire lo sviluppo della “cultura” a vantaggio della collettività verso cui l’evento si rivolge. In tal senso, la naturale distinzione in effetti positivi (benefici) e negativi (costi) risulterebbe limitata se non si applicasse anche quella in ritorni ‘tangibili’ (…) e ‘intangibili'”.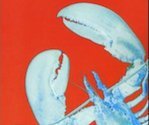 “Potrebbe essere benissimo che noi spettatori, privi dei doni divini degli atleti, siamo gli unici a essere davvero in grado di vedere, esprimere e animare l’esperienza del dono a noi negato. E che coloro i quali ricevono e mettono in pratica il dono del genio atletico debbano, di necessità, essere ciechi e muti al riguardo, e non perché la cecità e il mutismo siano il prezzo di quel dono, ma perché ne sono l’essenza”.
“Potrebbe essere benissimo che noi spettatori, privi dei doni divini degli atleti, siamo gli unici a essere davvero in grado di vedere, esprimere e animare l’esperienza del dono a noi negato. E che coloro i quali ricevono e mettono in pratica il dono del genio atletico debbano, di necessità, essere ciechi e muti al riguardo, e non perché la cecità e il mutismo siano il prezzo di quel dono, ma perché ne sono l’essenza”.