Il Festival 20 30, diretto da Nicola Borghesi, ha visto, nel 2016, la sua terza edizione. Abbiamo incontrato il direttore artistico del festival che ci ha raccontato come si è evoluto in questi tre anni il progetto: dalla voglia di alzare la mano e di esserci, attraversando l’idea di rivoluzione, fino alla missione di narrare il proprio presente, passando per la nascita della compagnia Kepler-452, i laboratori condotti in altre città, il coinvolgimento di attori non professionisti e la scoperta del reportage teatrale. “Siamo alla terza edizione del Festival 20 30 e siamo un po’ cresciuti insieme”, recita il programma e rilancia Borghesi durante l’intervista.
Quest’anno, tra il 13 e il 27 novembre, all’Oratorio San Filippo Neri di Bologna, con il finanziamento della Fondazione Del Monte, i numerosissimi spettatori (non paganti, perché “tutto scandalosamente gratis”) hanno avuto l’occasione di vedere: InvisibilMente di Menoventi, Albania casa mia di Aleksandros Memetaj, L’inferno dei viventi (finale di laboratorio) a cura di Kepler-452, Solopiano concerto di Giovanni Truppi e Lo Stato Sociale, Eppure manca qualcosa. I giardini dei ciliegi di Kepler-452. Ad ogni spettacolo, come nelle edizioni precedenti, è stato associato un laboratorio condotto dalle compagnie ospiti con partecipanti under30.
“Allora non si poneva questioni, e prendeva l’inferiorità degli adulti come un fatto naturale. Ora ne ha la conferma: nelle attuali condizioni il semplice svolgimento della vita porta, già nella maturità, al cretinismo”, recita l’epigrafe di Adorno del Festival, aprendo a una riflessione sul limine sfumato che i 20/30 attraversano, passando dalla giovinezza all’età adulta. Compiere questo passaggio, assumendosi la responsabilità di un’azione consapevole, sembra essere l’obiettivo di Borghesi e dei suoi compagni.
Nicoletta Lupia – Sono dell’opinione che un festival, soprattutto un festival che ha acquisito una certa consuetudine, sia come un discorso che il direttore artistico, l’associazione che lo cura, argomenta negli anni. Qual è il vostro discorso?
Nicola Borghesi – Credo che la risposta sia: ancora non lo posso sapere. Ma posso capire dove siamo arrivati fin qui. Essendo un discorso in fieri, il suo esito è imprevisto e ha molto a che vedere con le sorti della nostra generazione, con le evoluzioni delle nostre singole vite. Quello di cui mi sono accorto nel tempo è che molto di quello che succede nella direzione artistica, nella scelta dei temi, nell’organizzazione generale di un festival come il nostro, ha a che vedere con dei momenti della nostra vita. Nel tema di quest’anno è scritto: “Siamo alla terza edizione del Festival 20 30 e siamo un po’ cresciuti insieme”. Per me, questo è un romanzo di formazione. Ho cominciato a lavorarci a 27 anni e non sapevo niente di come si fa un festival, siamo arrivati a oggi, che ne ho 30, quindi, personalmente, sono in una delle due polarità che io stesso ho messo come discrimine del contenitore: i 30, del “20 30”. Questo, naturalmente, crea dei problemi anche di rimozioni identitarie. Il rischio più grande di fronte al quale mi sono trovato quest’anno è stato quello di continuare tutto uguale, di dare una consuetudine a una cosa che non può essere reificata in una forma standard in cui non c’entra nulla la fase in cui siamo.

Oratorio San Filippo Neri
Siamo partiti da un vuoto di sala, nel senso che, all’inizio, non sapevamo chi sarebbe venuto, e, io personalmente, da un vuoto personale, perché ero in un periodo della mia vita in cui non c’era più niente, tutti i miei impegni e i miei orizzonti erano azzerati, ero solo, qui, e non sapevo cosa fare. Di fronte a questo tempo vuoto, lasciato dalla mancanza di lavoro e di prospettive, c’era molto bisogno – un bisogno che rimane tuttora – di riempire di suoni, corpi, voci lo spazio. Anche ieri sera (13 novembre, durante l’esito di laboratorio condotto da Menoventi, ndr), in scena c’erano venti under 30. Nel tempo, anche e nonostante la scelta di temi specifici, il festival ha conservato la sua natura di spazio che va riempiendosi di corpi e di suoni. Fare numero, stare insieme, non perdersi di vista, basarsi sulla relazione, avere a che fare con qualcuno di specifico, un referente preciso, sono rimasti una costante. È la cosa che, ancor prima che iniziasse il festival, mi ha insegnato Cristina Pezzoli, quando mi ha chiesto a chi mi riferissi. Per anni, io non ho saputo a chi mi riferivo. Abbiamo cominciato (nel 2014, ndr), con la domanda più vaga possibile: chi saranno i 20-30 nel 2030? Ci siamo chiesti chi siamo, abbiamo alzato un braccio per dire: “Io sono qui”. L’importante era farlo ed esserci. Dopo questa prima edizione, mi sono messo a ragionare su che cosa avessi visto, cosa si potesse tenere di quella esperienza, in vista del secondo anno. Quello che ho colto era quello che io stesso avevo costruito: un ribollire magmatico di elementi, cose, corpi, relazioni, entusiasmi, soprattutto, desideri. Quello che, alla fine della prima edizione, appariva nella mia testa come speranza era la rivoluzione, cioè come queste azioni avevano rivoluzionato la mia vita e la visione di come sarebbe stato se, un giorno, questo cambiamento, accaduto in un tempo brevissimo, avesse investito un numero più ampio di persone. Allora, il secondo anno: la rivoluzione. E abbiamo sparato i grandi colpi, quelli più potenti. Tra la seconda e la terza, c’è stata la tournée de La Rivoluzione è facile se sai come farla (spettacolo prodotto nel 2015 da Kepler-452, ndr) in cui abbiamo aperto il cerchio e siamo andati in giro. Forse, il terzo anno, senza che questa necessità di relazione con un numero ampio di persone sia stata soppiantata, è subentrata una voglia di capire chi si è, non di raccogliere ciò che si è seminato – perché, tanto, non si semina e non si raccoglie niente, nel sistema teatrale italiano, se hai trent’anni –, ma di fare il punto sui momenti vissuti. Questo ha voluto dire, per me – e, forse, un po’, l’ho voluto anche imporre agli altri, perché penso ne avessimo bisogno tutti – capire dove fossimo e quindi cercare di definire meglio i contorni di una domanda che ci riguardasse ancora più da vicino e che affrontasse il vero rimosso: cosa c’è dopo? Dire “Proviamo a immaginare il cambiamento” è solo una parte del discorso. La consapevolezza che questo cambiamento non arriverà nel modo magico in cui lo abbiamo immaginato durante la seconda edizione, ci ha posto altre domande: come sopravviveremo? Potremo essere diversi? Potremo conservare qualcosa di tutto questo? E questa è la domanda di quest’anno: che adulti saremo? Che adulti siamo diventati? O, forse: che adulto sono?
NL – Mi sembra che, nell’ideazione del festival, la tua impronta di direttore artistico si percepisca molto. Ma, d’altra parte, è una responsabilità quella che ti assumi…
NB – Sono anni che me la assumo! Con i ragazzi del gruppo delle Avanguardie (gruppo di giovani under 30 che affianca il direttore artistico nella scelta degli spettacoli, ndr) abbiamo ragionato tantissimo, all’infinito. Sono usciti una quantità di temi, da Comizi d’amore, allo stato d’assedio, alla relazione col territorio. Io continuavo a dire che c’era qualcosa che non ci stavamo dicendo, perché era tutto troppo bello, tutto troppo giusto. Quando abbiamo centrato l’idea che il rimosso era chiederci che adulti saremo, tutti gli altri temi, nel lavoro di progettazione dei cinque giorni di festival, sono riemersi, perché, quando ci si mette in contatto con una rimozione, ci si sporcano le mani con un dato aspro, impresentabile, difficile da guardare.
NL – È la nostalgia del futuro.
NB – È la nostalgia del futuro! È valutare che cosa c’è di buono nella sconfitta che vive la nostra generazione. Siamo sicuri che sia un disastro il fatto che noi non abbiamo avuto il posto fisso e non abbiamo ereditato da nostro padre il posto in banca? In realtà, la terza edizione, più di quanto non sembri, è un discorso sull’alterità, sull’altro da sé, sul diverso, sul marginale e su come essere una generazione che fatica a inserirsi ci farà conservare una quota di diversità, di non educabile, di diverso, rispetto al sistema dato, su come questa esperienza di crescita che ci hanno fatto vivere potrebbe inceppare il sistema, su come potremmo essere degli altri da sé. Nel crescere, nell’entrare nell’età adulta, c’è una quota di rinuncia a una parte di identità. È la dialettica dell’Illuminismo di Adorno. L’esergo del festival è un aforisma di Adorno, tratto da un frammento che si chiama Segnati, in cui lui dice: c’è un certo punto della vita, verso i quaranta, cinquant’anni in cui ci si guarda intorno e si scopre che le relazioni che si hanno sono squallide, che la gente che è cresciuta insieme a noi sembra sia finita male e si pensa che questo sia il destino specifico di una generazione; poi ci si accorge che, quando si era giovani, si aveva già avuto questa idea di squallore ed era il proprio punto di vista sugli adulti. Quindi, al tempo, era naturale sentirsi superiori al mondo degli adulti, perché c’era qualcosa di strano in loro. Poi, invece, Adorno dice che affrontare il cambiamento, che è lo scotto da pagare per entrare in quel periodo della vita, porta al cretinismo, è come se fosse il prezzo da pagare per aver disatteso un desiderio della giovinezza, per aver rinunciato a ciò che si aveva deciso.
Credo che il punto del discorso del festival al quale siamo arrivati sia questo.
NL – Come tutto questo si rispecchia nel programma del Festival?
NB – Quest’anno ci abbiamo messo tanto tempo a scegliere il tema. Infatti, l’anno scorso, l’avevamo messo nel bando, quest’anno abbiamo preferito fare il contrario: valutare cosa arrivava, confrontandolo con dove eravamo noi, capire dove andava il nostro principio di piacere, attraverso un oggetto concreto come uno spettacolo e, in relazione alle scelte fatte, chiederci quale fosse il minimo comune denominatore tra le produzioni scelte. C’era tra noi un forte interesse per il cosiddetto teatro sociale, quindi un interesse verso determinati gruppi – immigrati, gruppi marginali, periferie, poveri – e io, come direttore artistico, ho pensato fosse necessario cercare di metterci tutti, me compreso, in guardia rispetto al rischio del teatro senza conflitto, che è un rischio nel quale io, quando lavoro con i professionisti, spesso cado. Come possiamo parlare di cose sulle quali siamo tutti perfettamente d’accordo, perché siamo tutti studenti universitari con le Clarks e con un grado di istruzione medio-alto che ci porterebbe a non votare mai Trump? Possiamo uscire da questo punto di vista, non facendo una cosa che per noi è rassicurante, ma è assolutamente ininfluente per chi non la pensa come noi? Insomma, abbiamo cercato di evitare le grandi pacche sulle spalle. Quindi, è uscito Albania casa mia che, pur essendo una storia di immigrazione, aggiunge un dato autobiografico, anche molto scanzonato, molto dritto e che porta in scena quel mondo senza l’infingimento buonista, che spesso tende a venire dall’esterno, sul destino del povero immigrato. Questo, secondo me, rispetto al tema e a ciò che vediamo, è, da parte delle Avanguardie, uno scarto interessante: scegliere una cosa del genere, priva di qualunque pietismo su un argomento che ci tocca molto da vicino, è un dato forte.
Per quanto riguarda i Menoventi, ho chiamato una compagnia che mette in scena due attori che, oggi, hanno 39 e 37 anni. Ho contravvenuto a tutte le regole che mi sono sempre dato. Perché? Perché era bello e perché erano anni che volevo chiamare InvisibilMente di Menoventi, lo trovavo giustissimo per il tipo di pubblico, giustissimo come operazione e giustissimo per i 20 30. Peraltro, mi sembra che la compagnia abbia fatto questo spettacolo quando gli attori avevano più o meno trent’anni. Per la prima volta, mi sono preso la libertà di rompere una regola che finora aveva sempre funzionato e per me è stato un atto di adultità, senza contare che il tema dello spettacolo si interseca potentemente con quello del festival, perché parla di qualcuno che ti dice cosa fare, della confort zone nella quale tu non devi decidere mai niente e qualcuno te lo spiega, di quello che volevi e potevi fare e che, alla fine dello spettacolo, non hai fatto. Anche nel finale di laboratorio condotto da Menoventi si rispecchia questo tema, ma secondo altri mezzi, perché si percepisce che c’è molto lavorio per entrare nell’età adulta, ma nessuna effettiva entrata, o, comunque, un ingresso disperato in quella fase della vita.
Per quanto riguarda, invece, Lo Stato Sociale, anche loro hanno partecipato alla prima edizione, quando non erano ancora nell’onda di successo strepitoso in cui sono stati negli ultimi anni. Il primo anno hanno fatto un concerto, il secondo anno hanno partecipato al processo artistico di Kepler curando le musiche – cosa che fanno anche in questa edizione – e quest’anno ho chiesto loro di tenere un laboratorio. Una cosa del genere, per loro, che vivono nella retorica del “non so fare niente eppure faccio cinquemila paganti”, vuol dire mettersi in contatto con un dato da trasmettere, dato che loro hanno perché il loro percorso è entusiasmante e ha qualcosa a che vedere con l’ingresso nell’età adulta, la possibilità di mettersi nella condizione di insegnare qualcosa.

Solopiano
Giovanni Truppi idem: lui fa un bellissimo discorso su come non si entri bene nell’età adulta, sul rimanere stramboidi.
Poi, presentiamo due produzioni di Kepler. L’inferno dei viventi nasce in tempi non sospetti, quando ancora questo tema non era stato scelto. Dovevo fare un lavoro su Dante (nella primavera del 2016, in occasione di un laboratorio tenuto nel contesto di Ravenna Festival, ndr), ho preso la Divina Commedia e mi è venuto il terror-panico, aiuto, paura. Il rischio era enorme. Allora, ho parlato con Paola Bigatto che è, secondo me, la più grande referente che esista in questo Paese sul rapporto tra Dante e il teatro, e lei mi ha detto una cosa che mi ha salvato e che mi salverà ancora: quando ti trovi davanti a un Moloch di tal fatta, devi tenere fermo un punto, decidere qual è l’unica cosa che hai capito e tutto il resto andrà bene, ma bisogna capire qual è il punto di intuizione e di relazione con quella cosa. Quindi, sono andato a rileggere e in parte a leggere Dante e ho capito che l’unica cosa che mi interessava per quel lavoro era la domanda: qual è la parte di noi che non cambia mai? In Purgatorio c’è della gente che ha fatto delle cose peggiori di quelle fatte da quelli che sono all’Inferno e mi sono domandato, insieme a Paola, perché non finissero all’Inferno anche loro. E lei mi ha detto che era perché non erano mai usciti dalla loro nevrosi, non avevano mai avuto un momento in cui si erano guardati da fuori, ha sempre vinto in loro la parte di sé che non cambia mai. L’inferno non è altro che la parte realmente esistente di noi che non cambia mai, quella parte per cui, da quando eri all’asilo a ieri, di fronte allo stimolo x giungi alla reazione y.

L’inferno dei viventi
NL – È forse anche la parte più ideologica, quella che non cambia mai, l’unica alla quale non siamo disposti a rinunciare…
NB – …perché non siamo in grado. Non è una questione di scelta, riguarda l’assenza della possibilità di scelta, è l’Inferno, è l’immobilità, laddove Dio è eterno movimento. L’Inferno è pieno di movimento fisico, nell’assenza di movimento vero e viceversa in Paradiso. Quindi, mi sono messo a studiare con tutti i membri del laboratorio quale fosse la parte di loro eternamente identica, da quando erano piccoli fino agli anni che avevano – il più giovane ne aveva 17, il più vecchio 30. Poi, ho chiesto a un gruppo di scenografi che facevano il laboratorio di scenografia con Luigi Greco di costruire delle strutture in legno dentro le quali potessero entrare o con cui potessero relazionarsi, fatte a immagine e somiglianza di quella parte di loro che non cambiava mai. Quindi, abbiamo messo lo spettacolo dentro queste strutture. Rispetto al tema del festival, il “Non supereremo mai questa fase”, l’ingresso nell’età adulta, la relazione con ciò che non cambia mai di noi, mi sembra uno spunto importante.
NL – C’è anche un altro aspetto che mi sembra molto interessante del vostro progetto e che riguarda l’assunzione di una responsabilità pedagogica. Come funzionano le due anime del festival: l’anima che porta avanti un discorso estetico e tematico, che sceglie un programma di spettacoli e l’anima – la necessità – di associare sempre alla scelta tematica e di spettacoli una volontà di formazione laboratoriale?
NB – Queste due anime esistono, è una cosa che è successa ma non me ne sono accorto ed è una caratteristica molto forte del festival di quest’anno. Inizialmente, la necessità nasceva da tre questioni: dal fatto che mi sentivo solo, molto banalmente, dal fatto che sapevo che i laboratori sono un buono strumento di audience development, qualunque cosa voglia dire, e, molto più semplicemente, dal fatto che ho sempre avuto una certa abilità individuale nel tenere i laboratori. Quindi, ho pensato di mettere a frutto questa abilità. All’inizio, credo che questo lato estetico e questo lato laboratoriale, pedagogico fossero molto staccati, o tendessero l’uno a influenzare l’altro, laddove sarebbe stato meglio se fosse stato il contrario. Mi spiego meglio. La libertà di azione che ho trovato, a un certo punto della mia vita, nei laboratori, la quantità di spontaneità, di energia dei laboratori hanno, in alcuni momenti del percorso, influenzato il lavoro estetico. Probabilmente, sotto certi aspetti, anche impoverendolo, sicuramente attribuendogli una vitalità che non si trova di frequente negli spettacoli di prosa. Da un punto di vista estetico, tendevo a privilegiare la vitalità, in quanto essa ha un dato estetico più strutturato – che era uno dei miei rimossi, che lo rimarrà per sempre, o che, di certo, lo è tuttora. Quello che so è che questi ragazzi che ci seguono da molti anni, stanno crescendo con noi e ci tracciano la via, nel senso che ci vogliono molto bene, però non sono affatto accondiscendenti. Quindi, in realtà, l’incremento del dato estetico, di una maggiore raffinatezza, di una maggiore cura dell’aspetto anche formale sono cose emerse da loro. Quest’anno, a un certo punto, io mi sono commosso. Rispetto alle Avanguardie, non avevo un progetto organico e di coinvolgimento come nel caso de La rivoluzione è facile se sai con chi farla. Mi sono messo a proporre varie cose e, a un certo punto, mi hanno detto: “Nicola, è chiaro che, in questo momento, stai pensando ad altro, perché ci devi coinvolgere in una cosa che tu stesso non sai bene cos’è? L’anno scorso era evidente che avevi bisogno di questo incontro con noi per fare quel lavoro. Il lavoro che stai facendo in questo momento – Eppure manca qualcosa. I giardini dei ciliegi – è un lavoro che sta andando in un’altra direzione. Mollaci. Non ci coinvolgere, se non hai bisogno di noi”. Dopo questa dichiarazione, loro hanno seguito molto le prove dello spettacolo, ma senza entrarci. Hanno condiviso con me il percorso di questo spettacolo e sono diventati un gruppo, in questo frangente. Mi hanno seguito in un mio percorso di scoperta e hanno avuto anche la comprensione di dirmi di non coinvolgerli.
NL – Il tema dell’emancipazione mi sembra un altro tema forte.
NB – È stato potentissimo.
NL – Cosa fa Kepler-452, oltre al Festival 20 30, durante il resto dell’anno?
NB – Pensiamo… (ride, ndr). Kepler ha compiuto un anno il 21 settembre e il suo primo anno è stato ricco di cose. Siamo partiti dal Festival che rimane, per il momento, il cuore dei nostri lavori, nel senso che ci debuttiamo e i ragionamenti dell’anno si concretizzano lì, ma ci sono di mezzo altre cose. C’è stata la tournée de La rivoluzione è facile se sai come farla, con più di venticinque date in tutta Italia. Lo spettacolo ha debuttato a novembre e ha girato molto, tra febbraio e giugno-luglio. È un exploit notevole per una compagnia giovane. Sono state tutte date che hanno vissuto sullo sbigliettamento. Abbiamo fatto – anche se è brutto a dirsi – sold out ovunque siamo andati e abbiamo cercato di portare l’idea di pubblico del Festival fuori dall’Oratorio San Filippo Neri (lo spazio dove si tiene ogni anno il Festival 20 30, ndr).
La scommessa è stata vinta, con un travaso di pubblico da quello de Lo Stato Sociale, dal mondo della musica indie-rock, da quel tipo di narrazione e di fruizione della cultura, verso di noi. Naturalmente, è stata una tournée faticosissima perché, a volte, eravamo a teatro, a Lecce eravamo al Teatro Koreja, ma, in altre città, eravamo nei club musicali, quindi abbiamo incontrato anche una disabitudine allo stare a teatro che, per i primi venti minuti di spettacolo, ha voluto dire lottare col coltello in mano per dire a tutti che stavamo facendo un’altra cosa rispetto a quella che si aspettavano. Però, lo spettacolo funziona perché è tarato per questo tipo di operazione. Poi, c’è stato “bè bolognæstate” (cartellone di attività culturali promosso e coordinato dal Comune di Bologna, ndr), durante il quale abbiamo presentato uno spin-off de La Rivoluzione è facile se sai con chi farla, un approfondimento di uno dei lavori del Festival, nel quale abbiamo aggiunto gli attori professionisti e i reportage dalla città – il genere del reportage teatrale ha poco a che vedere con quello giornalistico, ma registra climi, atmosfere, impressioni. Stiamo strutturando un gruppo di attori che cerchi di sviluppare l’abilità specifica, che non è un’abilità attoriale in senso stretto, di andare in un posto e registrare un clima da riproporre su un palcoscenico. Siamo andati a Fabbrico, andremo a Udine, a Faenza, per Accademia Perduta, a trovare i rivoluzionari di quel luogo. Poi c’è stata l’esperienza con Ravenna Festival e il lavoro su Dante di cui parlavamo prima, che è stata veramente una pietra nuova in un pezzo di percorso nel quale, appunto, ci siamo trovati necessariamente a lavorare su un dato site-specific e, quindi, a sviluppare un’estetica di strutture, scenografie, rapporto con lo spazio nuova per noi.
Poi c’è un’ovvia parte gestionale, orribile, terribile, che io soffro tantissimo, di fatture, ricerca e scrittura di bandi, rendicontazioni, depressioni. Nel resto del tempo, io insegno, faccio laboratori. Kepler, nella sua concezione, è una porta aperta. Kepler, in questo momento, sono soprattutto io, perché io sono quello che tutte le mattine si sveglia e pensa solo a Kepler. Le altre persone entrano ed escono, alcune restano. Livio (Remuzzi, ndr) che ha fatto con noi La Rivoluzione è facile se sai come farla, adesso è in tournée con Branciaroli e nessuno gli ha giurato vendetta per questo. Altri restano. Paola (Aiello, ndr) resta – anche se non ci siamo giurati fedeltà eterna, e meno ce lo diciamo più funziona –, perché è in tutti i progetti e stiamo già pensando a cosa fare insieme la prossima volta. Giuseppe (Attanasio, ndr) ha fatto La Rivoluzione è facile se sai con chi farla, questa estate e sta condividendo con noi questo pezzo di percorso. Enrico (Baraldi, ndr) ha fatto l’aiuto regia e ha pensato e progettato Eppure manca qualcosa con me. Insomma, è un insieme di energie che si basa ancora sul mio fulcro, ma che sta assumendo autonomia. È entrata Michela Buscema, un’organizzatrice, e questo ha portato un’altra quota di indipendenza e di delega. Poi ci sono Letizia Calori e Luigi Greco che non si occupano a tempo pieno di teatro, essendo rispettivamente un’artista visiva e un architetto. Bebo Guidetti, che si occupa per noi delle musiche, il resto del tempo fa il beatmaker dello Stato Sociale, di cui Lodo Guenzi, che ha fatto con noi La rivoluzione è facile se sai come farla, è il cantante. Kepler è una struttura in fieri che non so dove vada a finire, ma che, per come è strutturata adesso, è molto adatta a tutti, anche a me. Altri componenti del gruppo fanno anche altri lavori. Enrico fa ancora la Paolo Grassi, Beppe ha fatto altre tournée, Paola fa un progetto bellissimo sulle letture pubbliche dei romanzi Harmony nei bar che fa davvero ridere. Questo è quello che tendiamo a fare il resto dell’anno.
NL – Com’è nata la vostra produzione di quest’anno per il Festival, Eppure manca qualcosa. I giardini dei ciliegi?
NB – Eppure manca qualcosa. I giardini dei ciliegi è stata l’esperienza più potente di sempre, credo. La domanda da cui siamo partiti è una domanda che poi si è rivelata molto più ampia di quanto non immaginassimo all’inizio, ed era: di chi sono i posti? A chi appartengono i luoghi? Io non volevo rinunciare a un dato che sta diventato, credo, peculiare di questa compagnia: il lavoro con i non professionisti in scena, la narrazione delle identità individuali. Per I giardini immaginavo di fare una cosa simile. Quindi, volevo far partecipare dei non professionisti legati al tema specifico: persone che abitano i luoghi dell’anima e che ne vengono cacciati, che, in qualche modo, li perdono, per motivi economici. Nel Giardino dei ciliegi accade questo e, come abbiamo fatto con Dante ne L’inferno dei viventi, questo è il punto fermo che ho tenuto da Cechov e che trovo sia un’ulteriore declinazione del rapporto tra magia e Illuminismo di cui parla Adorno. Ermolaj Alekseevič Lopachin ha ragione a dire che non c’è via d’uscita? Lopachin ha ragione a dire che l’unica soluzione razionale per tutti sia tagliare quegli alberi, tirare giù quella casa e fare i villini per i villeggianti con il turismo di massa che bussa alle porte della Russia di fine Ottocento? Naturalmente, portiamo in scena un conflitto insanabile tra chi ha ragione e chi non ne ha, ma, non avendola, ha più ragione degli altri, e così all’infinito.
NL – Torna il discorso sull’ideologia e su quella parte di noi che non riusciamo a mettere a tacere.
NB – Esatto. Leonid Andreevič Gaiev e Ljubov’ Andreevna Ranevskaja sono all’inferno. Il giardino dei ciliegi è anche un inferno per loro, infatti, quando lo abbattono, lei dice di sentirsi meglio, ora che non c’è più niente da fare. Sono dei meravigliosi sconfitti. Quindi, ho cominciato a domandarmi quali siano i giardini dei ciliegi qui: Atlantide, Ex Telecom, i murales di Blu eccetera, eccetera. Quindi, il dato estetico era abbastanza in linea con il precedente de La Rivoluzione è facile se sai con chi farla. Il limite di quella struttura, che è anche la sua forza, è la presenza di tanta gente in scena che parla di sé. Il tempo che ho io per stare con loro e metterli in scena è relativamente poco. Io credo di avere un’abilità nell’individuare subito dei dati identitari e metterli in una forma, però è anche vero che poco tempo corrisponde spesso a poco approfondimento. Si può portare in scena un’intuizione, ma, in questo caso, ho voluto fare un’altra cosa.

Eppure manca qualcosa. Il giardino dei ciliegi
A un certo punto, ho conosciuto Giuliano e Annalisa Bianchi. In un articolo su Pilastro2016 (progetto di sviluppo dell’area del Pilastro promosso dal Comune di Bologna, ndr), si parlava di una strana famiglia che abitava in un immobile in comodato d’uso gratuito del Comune, in via Fantoni, di fianco al Link, che era stato sgomberata, per una ragione che era in relazione al progetto Pilastro2016. Sono andato a conoscere Giuliano e Annalisa. Giuliano nella vita si occupava, e ancora, in parte, si occupa di gestione della popolazione dei piccioni. I piccioni sono troppi e qualcuno deve gestirli. L’Ente veterinario non lo può fare direttamente per una serie di ragioni e affida questo compito a una terza persona. Giuliano era il braccio dell’Ente veterinario: catturava i piccioni, li faceva analizzare, se erano sani, li sterilizzava, se non erano sani, li sopprimeva, con uno strumento che si era inventato lui, cioè la camera di eutanasia per piccioni. Nessuno fa questa cosa in Italia, Giuliano è l’unico che ama abbastanza gli animali da fare questo lavoro in questo modo: ha costruito uno scatolo in cui c’è una ventola che tira fuori l’ossigeno, un’altra che spara dentro il monossido di carbonio e addormenta i piccioni dolcemente. Il mestiere di Giuliano era quello che io spiego così, ma sulla cui definizione lui non sarebbe d’accordo perché non esiste una definizione su cui lui è d’accordo. Nello spettacolo c’è una scena in cui tento di spiegare il suo lavoro e lui mi dice sempre che ho torto – mentre, finché parlo di altro, mi dà sempre ragione –, perché è un lavoro che si coglie con lo spirito e non con le azioni che si compiono e solo in relazione a un’altra parte del suo lavoro. In questa casa colonica, concessa dal Comune per fare questo lavoro, lui ospitava anche tutti gli animali pericolosi o selvatici o esotici che la gente non poteva più tenere e che non voleva dare alla Protezione animali perché non si sa bene che fine facciano. Quindi, Giuliano viveva in questa casa con sua moglie Annalisa, le sue figlie e una quantità di animali assurdi: maiali, vacche, cani, gatti, un boa constrictor, un babbuino, una tarantola pericolosissima spara-aculei, una vipera del Gabon, una lumaca gigante, dei fennec – delle specie di volpi del deserto –, per un periodo, un leopardo cucciolo che stava libero in casa, un lupo che stava libero, come dice Giuliano, “nel suo territorio”, che non si capisce quale sia, una famiglia di Rom, perché avevano bisogno. Giuliano dice che i Rom sono “i più individualisti di tutti”, che è la generalizzazione sugli zingari più bella che si sia mai sentita, secondo me. Malgrado questo suo pregiudizio, ne ospitava due a casa sua, insieme a numerosi carcerati in Borsa Lavoro. Era l’unico non cattolico che distribuiva gli aiuti alimentari a chi ne aveva bisogno. È un comunista vecchio stampo, un comunista dogmatico alla vecchia maniera che ha, a suo modo, ragione su tutto, per quanto mi riguarda. Quindi, per trent’anni, lui vive questo menage improbabile, marginale. È un pazzo, uno strano che, per trent’anni, trova un modo incredibile di vivere aderendo a chi è veramente.
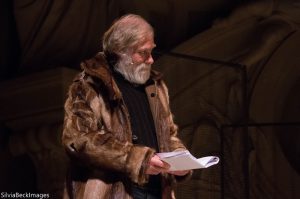
Eppure manca qualcosa. Il giardino dei ciliegi
Lui è, come dice Gaber, il signor Bianchi in ogni momento perché non ha problemi di comportamento, perché la distanza tra chi è e ciò che fa e come si comporta e come si muove all’interno del mondo è piccolissima. Rispetto alla rinuncia a una parte di sé, lui non ha rinunciato a niente, è rimasto così. E Annalisa pure. Hanno una storia d’amore straordinaria, sembrano due fidanzatini, si insultano, si picchiano, si amano e stanno insieme da quarant’anni. Per trent’anni hanno vissuto in questa casa, dove sono stati felici. Una volta ho chiesto a Giuliano quale fosse il ricordo più felice che aveva in quella casa e lui mi ha detto: “Non lo so, perché, per trent’anni, mi sono svegliato sempre felice, io”. Se sei una cosa e ti organizzi e la assecondi è ovvio che ti svegli sempre felice. Nell’aforisma di Adorno da cui parte il Festival c’è una seconda parte, un’appendice, che dice che si può rimanere uguali a sé, si può essere altro, si può non adeguarsi, ma la realtà presenta sempre il conto e ti fa diventare, nel migliore dei casi, un nevrotico, un picchiatello, uno strano. Cosa che Giuliano era già, in qualche modo, per l’esterno, probabilmente, ma la realtà gli ha presentato il conto e gli ha sparato al cuore. Oscar Farinetti ha deciso di fare FICO (struttura per la divulgazione e la conoscenza dell’agroalimentare, ndr) proprio di fronte a casa sua. Ovviamente, non è dimostrabile alcuna relazione tra questi due fenomeni, però, da quando sono cominciati Pilastro2016 e FICO, lui non ha potuto più stare lì. Gli hanno presentato il conto seriamente, nel senso che lo hanno accusato di maltrattamento sugli animali, gli hanno fatto dei controlli a sorpresa e hanno sostenuto che lui non rispettava delle norme o, forse, non le rispettava alle cinque del mattino quando sono andati a perquisirgli la stalla. Giuliano è stato sgomberato: sono arrivati una mattina, in cinquanta, dicendo che lui era pericoloso – ed è vero, può esserlo – e il Signor Bianchi è stato sgomberato, insieme ad Annalisa. Li hanno messi al Galaxy che è il posto in cui, in questa città, sbattono i poveri e gli sgomberati, un casermone in cui ci sono quattrocento poveri di varia estrazione e nazionalità. Adesso Giuliano e Annalisa vivono in un appartamento di quattro metri per sei, con Ara, un pappagallo gigante di 65 anni, un gatto e, in una piccola gabbietta, un piccione. Loro stanno lì dentro, non hanno più niente, non possono più lavorare, hanno perso tutto, perché la realtà presenta sempre il conto a chi non si adegua, in un modo o nell’altro. Non c’è un complotto, non c’è un progetto, succede, è un meccanismo tarato, funziona, l’Illuminismo funziona: a un certo punto, il conto arriva. Loro sono stati molto fortunati, il conto è arrivato tardi, per trent’anni sono stati felici che è una cosa importante perché, nella vita delle persone, di solito, non ci sono trent’anni di felicità. Quindi, noi, a un certo punto, abbiamo detto: lo spettacolo sarà solo su di loro. È seguita una fase di lungo corteggiamento in cui è nata un’amicizia profonda, intensa, grande e bella tra persone molto diverse tra loro. Giuliano è una persona in grado di stupirti ogni volta, perché è l’altro da sé. Ieri si è presentato con un mazzetto di erbetta e mi ha detto: “Sai cos’è questa, coglione? La cicuta! L’ho trovata per terra in Via Zanardi. Con questa qua dormi, eh!”. Ogni giorno, Giuliano stupisce, in qualche modo, è una cosa bellissima.
NL – Come avete fatto a mettere in relazione questa storia con Il giardino dei ciliegi?
NB – Mi hanno spiegato loro come fare. Io, come sempre, partivo dal mio presupposto: i non professionisti raccontano la loro storia e noi mettiamo in scena delle parti de Il giardino dei ciliegi, in qualche modo, e Giuliano mi ha detto “No, non la dico la storia io, perché è troppo viva, perché mi fa troppo male, perché non dormo più la notte, perché non voglio ricostruirla”. Rimaneva solo la possibilità che loro facessero Il giardino dei ciliegi. Quindi, loro fanno Ljubov’ Andreevna Ranevskaja, Leonid Andreevič Gaiev e Firs e noi raccontiamo la loro storia. Tecnicamente, perché fare uno spettacolo teatrale e non un documentario, che sarebbe un bellissimo documentario, sulla storia dei Bianchi? Su questo mi sono arrovellato per i primi giorni di prove. Poi ho capito che non dovevamo fare un documentario e nemmeno raccontare la loro storia perché ci sono strumenti più adatti del teatro. Noi raccontiamo della nostra relazione, lo spettacolo è un reportage su tre momenti del nostro incontro: la prima volta che io e Beppe siamo andati al Galaxy ed è stato il nostro primo ingresso nel loro mondo; quando siamo andati a rubare con loro a casa loro – una casa in cui lui aveva costruito un termosifone per un babbuino – delle cose, di nascosto, come dei ladri; il giorno dopo, quando loro, benché avessero 56 euro sul conto corrente, ci hanno invitato a pranzo a casa loro a mangiare il polpo, perché, ci dice Giuliano, è l’unico pesce che non si può allevare. Sono dei signori, sono dei nobili decaduti come Ljubov’ Andreevna Ranevskaja e Leonid Andreevič Gaiev. Infatti, loro fanno i due personaggi con una quota di aderenza tale che io credo che non si potrà più fare Il giardino dei ciliegi dopo di loro. Ovviamente, non è vero. Ma l’imbarazzo che prova Beppe, che fa Lopachin, nel dire loro, che hanno quella storia, “Naturalmente bisognerà abbattere questa casa e tagliare il giardino dei ciliegi” e il tasso di aderenza con cui Giuliano dice: “Ma che sciocchezze state dicendo?”, o Annalisa risponde: “Non vi ho capito bene”, creano dei cortocircuiti potenti.

Eppure manca qualcosa. Il giardino dei ciliegi
In conclusione, a proposito di cos’è Il giardino dei ciliegi: è un discorso su dove siamo noi, sulla posizione che abbiamo io, Paola e Beppe rispetto al giardino. Che posizione abbiamo rispetto a Giuliano? Diventeremo come lui o come i nostri genitori? Supereremo questa fase ed entreremo nel mondo degli adulti? Perché io non voglio che mi si presenti il conto a un certo punto. Io non voglio diventare così, ma non voglio neanche diventare come Giuliano e pagarne lo scotto. Noi siamo nel mezzo del guado, o forse nemmeno più. Rispetto a tutto il dato formale che tu citavi, di incontro tra estetica e relazione, laboratori, pedagogia, eccetera, secondo me, molto immodestamente, in questo momento, si è trovata la quadra, perché è tutto giusto, per una volta, il nostro incontro con loro, il modo in cui abbiamo affrontato questo mese di prove e il mese di studio, il modo in cui ci siamo relazionati con loro sono tutti giusti e ci stanno cambiando la vita, a noi e a Giuliano e Annalisa. Ieri Giuliano mi ha detto una cosa, riferendosi allo spettacolo: “Questa cosa qua è come essere sbattuti in una doccia meravigliosa che fa rifiorire un po’ tutto”. Io gli ho detto che è un poeta e lui mi ha detto: “No, io sono uno che tien dietro agli animali, mica un poeta”.
Intervista a cura di Nicoletta Lupia







